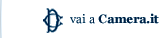Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
MOZIONE 1/00508 presentata da MARINACCI NICANDRO (FORZA ITALIA) in data 20010201
La Camera, premesso che: i gravi, repentini ma costanti mutamenti climatici interessano l'intero pianeta e, per la loro cadenza, non piu' eccezionale, ma sistematica, interessano, con gravi ripercussioni tutte le attivita' produttive ed in particolar modo il settore dell'agricoltura; nei giorni scorsi si e' tenuta all'Aja la VI conferenza internazionale sui cambiamenti del clima e in tale occasione gli scienziati partecipanti hanno ancor piu' confermato le dinamiche gia' rilevate da tempo e comunque in atto sulle modificazioni climatiche. In particolare, con riferimento all'area geografica di interesse italiano - il bacino del Mediterraneo - per comprendere come il clima sta cambiando, nella circostanza si e' specificato in modo figurativo che e' possibile immaginare una linea retta che taglia a meta' il Mediterraneo: a sud di questa il clima sara' sempre piu' siccitoso, a nord sempre piu' piovoso con eventi intensi, quasi sempre di alto volume in breve periodo; e' avvenimento recente la Conferenza internazionale di Bonn sulla desertificazione nel corso della quale e' stato evidenziato il rischio che anche nei paesi rivieraschi del Mediterraneo, quali l'Italia, possano determinarsi fenomeni di desertificazione, a seguito delle dinamiche di degrado territoriale instauratesi per effetto della reiterazione di fenomeni siccitosi; e' ormai pressoche' certo che in questo scenario svolga un ruolo determinante il fattore umano, cosi' come gia' evidenziato a Kyoto, anche se deve essere considerato che la vita della Terra e' caratterizzata da mutamenti climatici che vanno incessantemente da ere calde a quelle fredde, da ere umide a quelle secche; da tale scenario scaturisce la problematica che sempre piu' le popolazioni sia rivierasche che continentali del Bacino del Mediterraneo saranno costrette ad affrontare a ritmo crescente fin dal prossimo futuro: la difesa dalle acque da un lato, l'approvvigionamento difficile di risorse idriche e loro ulteriore razionale gestione dall'altro. In particolare, se la questione lascia intravedere aspetti di grande preoccupazione in quei territori che storicamente hanno avuto problemi di rapporti difficili con il ciclo delle acque, soprattutto a livello di disponibilita', in effetti tale problematica si rivela cruciale proprio per l'Italia, dato che la particolare collocazione geografica della penisola fa si' che il suo territorio partecipi in parti quasi uguali alle due situazioni di prospettiva anzidette: eventi pluviometrici abnormi e spesso disastrosi a carico dell'area continentale del Paese, siccita' spinta in quella mediterranea con pochi eventi idrometeorici degli ultimi anni, specie dello scorso autunno, sono la dimostrazione palese di questa prospettiva; di fronte a situazioni cosi' abnormi ne deriva che le metodologie di approccio complessivo alla problematica fin qui adottate e di per se' gia' inefficaci per contrastare e/o contenere i fenomeni di degrado del suolo (dissesto idrogeologico, franosita', erosione, alluvione, eccetera) da un lato e di grave penuria di approvvigionamento idrico, dall'altro, vanno totalmente riviste e rese piu' efficaci ed incisive per evitare, nelle differenti situazioni territoriali, i danni diretti (fin'anche di perdita di vite umane) e indiretti ben conosciuti. Soprattutto per l'area peninsulare piu' meridionale ed in quella insulare del Paese, non possono non essere sottolineate con preoccupazione le previsioni legate alla carenza di risorse, per gli effetti negativi che si determinano a livello di fruibilita' di vasti territori e di operativita' dell'uomo a livello civile ed economico, a seguito dell'instaurazione di ulteriori spinte verso i processi di degrado ambientale, ivi compresi quelli di desertificazione e abitativo; e cio' non solo quando non e' possibile soddisfare le piu' elementari esigenze di approvvigionamento civile e potabile, ma anche quando viene limitato significativamente l'esercizio dell'agricoltura specie nelle aree rurali piu' densamente popolate, dove i meccanismi di antropizzazione si integrano strettamente con i fenomeni di gestione del territorio e delle sue risorse (ambiente, paesaggio, eccetera) che in tal modo subirebbero effetti negativi quasi sempre irreversibili; va sottolineato, in questo quadro, che diventa precario proprio l'esercizio dell'agricoltura e collateralmente il soddisfacimento delle necessita' basilari alimentari ed economiche, dato che l'attivita' agricola gia' fin da ora manifesta condizioni di deficit idrico che non sono in grado di assicurare neanche il ristoro fisiologico delle esigenze d'acqua delle colture, oltretutto povere, attualmente praticate. Situazione, questa, di particolare gravita' nell'Italia meridionale, dove l'acqua svolge il ruolo fondamentale di fattore di produzione e non gia' di elemento utile per l'incremento delle rese, cosi' come ritenuto erroneamente dall'Unione europea in occasione dell'utilizzazione programmatica dei fondi del quadro comunitario di sostegno (QCS) 1994-1999; l'argomento irrigazione assume grande rilievo proprio in Italia, tenuto conto che circa i due terzi delle risorse di acqua dolce nazionali sono adibite a questo uso e che proprio l'agricoltura meridionale del Paese, con una superficie irrigata pari a circa 1.600.000 Ha, non puo' fare a meno di tale supporto determinante, oltretutto in presenza di una forte propensione all'estendimento dell'area servita; propensione, tuttavia, sempre piu' limitata dalla carenza di risorse. E non e' per caso, del resto, che soddisfatte le elementari esigenze di approvvigionamento idrico civile e potabile, e l'agricoltura il successivo obiettivo prioritario di destinazione delle risorse, cosi' come disposto anche per via legislativa dalla cosiddetta legge Galli; a fronte della situazione esposta, si pone all'attenzione il problema di verificare con la massima urgenza quali siano le fonti di approvvigionamento idrico idonee per assicurare la gestione dell'agricoltura irrigua in Italia ed in particolare se e' possibile accrescerla rispetto allo scenario che i cambiamenti climatici in atto determinano e ancor piu' saranno in grado di determinare; nella prospettiva di mancato o anche ridotto apporto pluviometrico, tenuto conto della limitata praticabilita' di tecnologie oggi adottabili ma certamente assai costose (quali la dissalazione e il trasferimento di acqua a grandi distanze) o rischiose sotto l'aspetto ambientale (quali l'agricoltura con acque salinizzate), appare essenziale adottare urgenti iniziative tecnico-progettuali sia di consolidamento delle attuali superfici irrigabili, sia di completamento degli schemi idrici irrigui in atto, soprattutto con riferimento alla ristrutturazione e ammodernamento delle reti di distribuzione esistenti, sia infine di accrescimento della disponibilita' di acqua al fine di soddisfare le nuove esigenze di trasformazione irrigua dell'agricoltura - specie in quelle aree collinari che pur avendo terreni eccellenti sono infruttiferi per carenza idrica -. Al riguardo, con particolare attenzione, potra' essere valutata la soluzione di valorizzare a fini irrigui le acque reflue rese idonee, l'incentivazione per convogliare acque meteoriche a monte di tali aree, nonche' la possibilita' offerta dall'adozione di tecnologie di interventi sul clima per accrescere gli eventi pluviometrici; impegna il Governo a preordinare un programma diretto a: consolidare l'agricoltura irrigua nelle aree meridionali del Paese, con particolare riguardo a quelle ricadenti in Puglia, Sicilia e Sardegna; completare, ristrutturare e ammodernare gli schemi idrici in atto, specie quelli derivati dall'intervento straordinario nel Mezzogiorno; realizzare nuove strutture di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua a fini multipli, ma con prevalenza per quelli irrigui; utilizzare, ai fini del reperimento di nuove fonti di approvvigionamento, le piu' avanzate tecnologie di recupero di risorse ivi comprese quelle relative agli interventi sul clima; verificare la capacita' di enormi sacche di acqua dolce site a piccole profondita' nell'area del Gargano e rilievi montuosi delle altre regioni interessate affinche' possano, con pochi investimenti, risolvere, almeno in parte, tale drammatico problema; utilizzare altresi', per la copertura di spese, i fondi residui relativi alla legge n. 64 del 1986 cui la ripartizione e' imminente, da parte del Cipe, relativamente all'anno finanziario 2001. (1-00508)