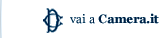Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
MOZIONE 1/00298 presentata da PETROCELLI VITO ROSARIO (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 06/08/2014
Atto Senato Mozione 1-00298 presentata da VITO ROSARIO PETROCELLI mercoledì 6 agosto 2014, seduta n.301 PETROCELLI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, DONNO, FUCKSIA, MANGILI, MOLINARI, PAGLINI, SANTANGELO, SERRA - Il Senato, premesso che: i costi dell'energia rappresentano un parametro centrale, anche se non unico, attorno al quale valutare la sostenibilità di una strategia energetica e di una politica economica. Il nostro Paese ha la necessità di abbattere i costi energetici attraverso una più attenta valutazione delle modalità di produzione e/o approvvigionamento e distribuzione dell'energia elettrica e dell'energia termica per il riscaldamento domestico e industriale; la relazione della UE sui prezzi e i costi dell'energia, del 29 gennaio 2014, mostra che fra il 2008 e il 2012 i prezzi al dettaglio dell'energia in Europa sono aumentati bruscamente, nonostante quelli all'ingrosso dell'elettricità siano calati e quelli del gas siano rimasti stabili. Si registrano inoltre forti differenze da un Paese all'altro: alcuni consumatori pagano da 2,5 a 4 volte di più rispetto ad altri; il dossier su "I costi dell'energia in Italia", realizzato dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile nel 2013, evidenzia come la bolletta energetica pagata da famiglie e imprese in Italia è del 18 per cento più alta rispetto alla media europea e allineare i prezzi dei prodotti energetici italiani (energia elettrica, gas e carburanti) a quelli medi europei vorrebbe dire risparmiare ogni anno 25 miliardi di euro; i dati forniti dal gestore servizi energetici, dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e dalla Commissione europea nel Contributo al Consiglio europeo del 22 maggio 2013 relativo a "Politica e sfide nel settore energetico", hanno consentito alla Fondazione per lo sviluppo sostenibile di quantificare, per l'anno 2013, in 4 miliardi di euro i costi aggiuntivi per le famiglie italiane rispetto alla media europea per il gas naturale (pagato mediamente tra il 24 e il 35 per cento in più); per le piccole e medie imprese italiane c'è invece un aggravio di ben 12 miliardi di euro (il gas naturale è pagato dal 7 al 21 per cento in più, mentre il costo del kilowatt ora va dal 30 all'86 per cento in più rispetto alla media europea, che vede avvantaggiata in Italia solo la grande industria che, per sconti fiscali, ottiene un 9 per cento in meno sul prezzo del gas naturale rispetto alla media europea); secondo quanto riferisce lo stesso studio, l'Italia è uno dei Paesi a più alta dipendenza da combustibili fossili in Europa: stando ai dati Eurostat aggiornati al 2011, l'82 per cento del fabbisogno energetico nazionale è soddisfatto tramite importazioni fossili, contro una media della UE a 27 Paesi del 54 per cento, il 76 per cento della Spagna, il 61 della Germania, il 48 della Francia e il 36 per cento del Regno Unito. Dopo Regno Unito e Germania, l'Italia è il primo consumatore di gas naturale. L'utilizzo del gas è preponderante nella produzione di energia termica (domestica e industriale) e di energia elettrica; le risorse interne di gas riescono a coprire circa il 6-7 per cento della domanda, facendo sì che tale dato si traduca in una fattura energetica estera, a favore dei combustibili fossili e delle economie (e dell'occupazione) di Paesi terzi, rilevante in termini assoluti; nella sezione III del Documento di economia e finanza 2014, contenente il programma nazionale di riforma, parte I "La strategia nazionale e le principali iniziative", il Governo indica tra le azioni da porre in essere la riduzione, di almeno il 10 per cento, dei costi energetici per le imprese, nonché la «maggiore diversificazione degli approvvigionamenti e il completamento del processo di liberalizzazione del mercato elettrico e del gas, anche rimuovendo gli ostacoli allo sviluppo della nostra capacità di rigassificazione»; nella parte II "Gli squilibri nazionali e le riforme in dettaglio" viene altresì ribadito che «l'Italia è tra i 14 Paesi che soddisfano il criterio N-1, cioè la possibilità di soddisfare la domanda di gas particolarmente elevata in mancanza della principale fonte di approvvigionamento»; rilevato che: in Italia lo stoccaggio di gas naturale è svolto in base a 15 concessioni vigenti. I siti di stoccaggio attivi sono 10, tutti realizzati in corrispondenza di giacimenti di gas esausti, con una capacità di erogazione pari a 15,6 miliardi di metri cubi, di cui 5,1 destinati allo stoccaggio strategico, già sufficienti, quindi, con un consumo di gas annuale di 70 miliardi di standard metri cubi, a garantire riserve per il 20 per cento del fabbisogno annuale di gas; per il trasporto del gas naturale, l'Italia si avvale di un'infrastruttura tra le più estese e articolate d'Europa. Snam svolge l'attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale avvalendosi di un sistema integrato di infrastrutture formato da circa 31.700 chilometri di metanodotti (articolati in 8.800 chilometri di rete nazionale e in 22.600 chilometri di rete regionale), un centro di dispacciamento, 8 distretti, 55 centri e 11 centrali di compressione; l'Italia può far affidamento su una rete di gasdotti articolata in 5 linee principali che portano il gas alla frontiera in corrispondenza dei punti di ingresso della rete nazionale e di terminali di rigassificazione. In particolare: il gasdotto TENP-Transitgas, che collega i Paesi bassi al passo di Gries (nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola), attraverso Germania e Svizzera, con una capacità pari a circa 20 miliardi di metri cubi all'anno; il gasdotto TAG, che collega Baumgarten (punto di consegna del gas russo al confine tra Austria e Slovacchia) a Tarvisio (Udine), attraverso l'Austria, con una capacità di 37 miliardi di metri cubi all'anno; il gasdotto TTCP-TMPC, che collega l'Algeria a Mazara del Vallo (Trapani), attraversando la Tunisia e il canale di Sicilia, con una capacità di 34 miliardi di metri cubi all'anno; il gasdotto Greenstream, che collega la Libia a Gela (Caltanissetta), attraverso il mar Mediterraneo, con una capacità di 10 miliardi di metri cubi all'anno; il settore del gas naturale è ormai da 10 anni oggetto di grande attenzione nell'ottica del potenziamento delle infrastrutture di importazione e della capacità di stoccaggio. A ciò occorre aggiungere che la strategia energetica nazionale afferma chiaramente la volontà di far divenire il nostro Paese piattaforma di scambio in grado di intercettare i flussi di gas sia sulla direttrice sud-nord, sia su quella est-ovest. Analizzando in dettaglio i piani di sviluppo di nuove infrastrutture di approvvigionamento è possibile osservare come esistano numerosi progetti in essere che, se integralmente realizzati, come si afferma nello studio "Il mercato del gas naturale in Italia: lo sviluppo delle infrastrutture nel contesto europeo", realizzato dalla Cassa depositi e prestiti, «porterebbero la capacità di ricezione del nostro Paese quasi a raddoppiare»; con riferimento ai progetti in essere si evidenziano 4 progetti principali: i progetti TAP e IGI, che dovrebbero consentire all'Italia di intercettare i flussi di gas naturale del corridoio sud che a sua volta dovrebbe convogliare risorse provenienti dall'Azerbaijan, dall'Iraq e dal Turkmenistan; il progetto GALSI, che prevede la realizzazione di un'interconnessione tra l'Algeria la Toscana, attraverso la Sardegna; il progetto TGL, che comporta la realizzazione di un flusso bidirezionale ( reverse flow ) tra Italia, Austria e Germania, coinvolgendo i mercati della Repubblica ceca e della Slovacchia; ancor più complesso il quadro relativo ai terminali di rigassificazione, per i quali si rileva una moltitudine di progetti, molti dei quali tra loro alternativi, con diverso stadio di avanzamento e discutibili necessità di realizzazione. A riguardo, occorre evidenziare che il "Focus sulla sicurezza energetica", realizzato dall'ISPI e relativo al periodo ottobre-dicembre 2013, afferma che dal punto di vista delle interconnessioni tra le reti del gas, «il sistema infrastrutturale nazionale appare pienamente adeguato». Inoltre, in considerazione del dato per cui le prospettive di crescita, soprattutto nell'ottica di un mercato comune su base europea, non giustificano un potenziamento delle infrastrutture con la creazione di nuovi terminali, non appare né strategicamente rilevante né economicamente ragionevole procedere nella costruzione di nuovi rigassificatori; valutato che: dall'analisi dei dati contenuti nel rapporto ENI 2013 e dei dati di Eurogas, si evince come i consumi di gas a livello europeo (UE a 27 Paesi) abbiano raggiunto un picco in corrispondenza dell'anno 2005 (528,10 miliardi di metri cubi), per poi ridursi ai 468 del 2012 ed ai 462 miliardi di metri cubi del 2013; in Italia i consumi sono passati dagli 84 miliardi di metri cubi del 2005 ai 70 del 2013, al di sotto del livello del 2002. Per il 2023 Snam stima una domanda di 74 miliardi di metri cubi, inferiore a quella del 2003; la produzione nazionale è passata da 653 milioni di metri cubi dello scorso anno a 595 milioni di metri cubi dell'anno in corso, ossia l'8,8 per cento in meno dell'anno passato; nel mese di maggio 2014 sono stati consumati 3.653,5 milioni di metri cubi di gas contro i 3.742,2 milioni di metri cubi consumati nel mese di maggio del 2013, con una diminuzione di circa il 2,4 per cento. Dal mese di marzo 2013 la diminuzione è stata costante e continua, mese dopo mese, con la sola eccezione del novembre 2013; i dati forniti dalla Snam mostrano la progressiva riduzione del consumo di gas, che ha raggiunto il livello più basso degli ultimi 10 anni, mai toccato dal gennaio 2006; la severa battuta d'arresto dei consumi di gas naturale registrata nel corso degli ultimi anni per effetto della crisi dovrebbero determinare un mutamento strutturale nell'assetto e nelle previsioni di crescita del settore; considerato che: in Italia si dispone, quindi, non solo di una quantità di gas più che sufficiente, se si considerano i volumi importati attraverso i gasdotti già attivi e quelli che dovrebbero arrivare qualora fosse conclusa la realizzazione dei progetti in corso, ma anche di un eccesso di produzione rispetto alla domanda di elettricità; secondo i dati forniti da Terna, a marzo 2014 la domanda di elettricità in Italia è stata del 3,7 per cento inferiore al marzo 2013, in linea con quanto accade da oltre un anno e mezzo; il primo trimestre dell'anno 2014 e i primi consuntivi su produzione e consumi elettrici in Italia, sempre in riferimento ai dati di Terna, mostrano che a livello di trimestre, il contributo delle fonti rinnovabili (inclusi circa 3 TWh di bioenergia) sulla produzione nazionale è del 39,8 per cento. Nel primo trimestre 2013 era stato del 32,4 per cento. Le rinnovabili hanno coperto quest'anno il 33,3 per cento, mentre lo scorso anno (gennaio-marzo 2013) tale quota era pari al 27,7 per cento; la percentuale del contributo del termoelettrico alla domanda (depurata dalla produzione di bioenergia) scende dal 57,9 per cento del 2013 al 50,4 del primo trimestre 2014. Sulla produzione si passa dal 67,6 al 60,2 per cento; nonostante la sovrapproduzione di forniture e stoccaggi di gas e di produzione di energia elettrica rispetto alla domanda di gas e di elettricità a livello nazionale, che la citata relazione della Commissione europea sulle "Politiche e sfide nel settore dell'energia" definisce ottimale per una diversificazione dell'approvvigionamento di gas per avere "prezzi più competitivi", non vi è stata nel nostro Paese un'effettiva e corrispondente diminuzione dei prezzi per i consumatori: famiglie e piccole e medie imprese; nel contributo della Commissione europea sul tema "Efficienza energetica: investire in una fonte energetica meno cara e più pulita", la medesima Commissione specifica che «il conseguimento dell'obiettivo dell'UE del 20 per cento di efficienza energetica entro il 2020, si traduce in un risparmio equivalente alla chiusura di 1000 centrali elettriche a carbone o a 500.000 turbine eoliche» in Europa e, di conseguenza, in percentuale statistica, anche in Italia. Inoltre, nel contributo si afferma che: «L'efficienza energetica riduce la domanda di energia, le importazioni di energia e l'inquinamento. Offre inoltre una soluzione a lungo termine al problema della carenza di combustibili e dei prezzi elevati dell'energia. Nonostante il ruolo fondamentale che l'efficienza energetica svolge in termini di riduzione della domanda, attualmente soltanto una piccola parte del suo potenziale economico viene sfruttata»; l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile sta vivendo a livello mondiale una forte crescita in termini di occupazione, fatturato, ed energia prodotta; tutta la generazione italiana da rinnovabili, circa 106,8 TWh, risulta pari al 38,5 per cento della produzione nazionale e al 33,7 per cento della domanda nazionale. Quindi più di un chilowattora su 3 richiesto in Italia oggi è prodotto da fonti pulite. Il fotovoltaico con i suoi 22,1 TWh prodotti copre il 7 per cento della domanda ( record mondiale) e l'8 per cento della produzione. Le rinnovabili elettriche nel complesso sono aumentate di circa 15,5 per cento rispetto al 2012; una maggiore efficienza energetica e un incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili comporterebbero non solo una riduzione delle richieste di gas ai fini della produzione di energia elettrica, e quindi una minore dipendenza energetica da altri Paesi e dalle importazioni di combustibili fossili, ma soprattutto un più agevole raggiungimento dei nuovi obiettivi comunitari proposti dalla Commissione europea per il 2030: 40 per cento di riduzione delle emissioni climalteranti, 27 per cento di rinnovabili sui consumi finali e 30 per cento di riduzione dei consumi energetici; considerato, inoltre, che: la crescita continua della produzione da fonti rinnovabili, a giudizio dei firmatari del presente atto nonostante gli interventi dei Governi succedutisi volti a frenarla, permetterebbe oggi finalmente di chiudere o riconvertire le centrali elettriche più vecchie e inquinanti; al fine di conseguire l'obiettivo comunitario di riduzione delle emissioni climalteranti, occorre tener presente che il carbone è, tra le fonti fossili, quella che per la produzione di energia elettrica emette maggiori emissioni di anidride carbonica (CO2). Uno studio titolato "Stop al carbone", realizzato da Legambiente nel 2013, mostra come «nel 2012 a fronte di un contributo pari al 16 per cento della produzione energetica italiana, le centrali a carbone hanno contribuito al 35 per cento alle emissioni di CO2 mentre, ad esempio, le centrali a gas, producendo il 45 per cento dell'energia elettrica hanno contribuito per il 42 per cento alle emissioni. Infatti per ogni kWh prodotto dalle centrali a carbone italiane vengono emessi 857,3 grammi di CO2, contro i 379,7 di quelle a gas naturale, o le emissioni zero delle centrali solari, eoliche, idroelettriche, geotermiche, a biomasse». Non è possibile poi tralasciare che il carbone costituisce una grave minaccia per la salute di tutti: la combustione rilascia infatti un cocktail di sostanze dannose (tra cui arsenico, cromo, cadmio, mercurio, polveri sottili), che interessano un'area molto vasta intorno alle centrali; secondo i dati del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2012, però, le centrali in fase di realizzazione sono 6 per 3.543 MW. Quelle in corso di autorizzazione alla medesima data addirittura 38 tra gas, metano, carbone, per 23.990 MW. A tali impianti vanno ad aggiungersi le centrali termodinamiche, strutture ibride di energia rinnovabile integrate da centrali a gas; di tali impianti dovrebbe occuparsi la strategia energetica nazionale al fine di ridurre le emissioni di gas serra, nell'ambito degli obiettivi comunitari, e i costi per il sistema connessi agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti fossili. La sovrabbondanza di centrali fossili già oggi comporta effetti rilevanti in termini di costi per aziende e cittadini; il contributo sempre più rilevante portato dalle fonti rinnovabili, ma con problemi nel dispacciamento per l'inadeguatezza delle reti in alcune Regioni e con un andamento in parte discontinuo, associato alla riduzione dei consumi, sta generando contraccolpi sugli impianti da fonti fossili, che vengono usati progressivamente meno ma che potrebbero servire come riserva; per affrontare gli stessi problemi, la Germania punta ad investire sulle reti per spostare l'energia prodotta da rinnovabili verso i luoghi dove è maggiore la domanda, sullo stoccaggio, per immagazzinare l'energia e poi, in ultima istanza, su un sistema di remunerazione per le centrali che svolgono un ruolo di riserva; al contrario, invece, l'Italia, a causa di una politica energetica miope, e sotto la pressione delle lobby , non interviene sulle reti (in particolare su quelle di distribuzione) e sullo stoccaggio, ma, in maniera del tutto irragionevole, continua ad erogare sussidi per vecchie centrali a combustibili fossili, consentendo deroghe alla normativa sulle emissioni in atmosfera o alla qualità dei combustibili; è evidente, quindi, che la strategia energetica nazionale non può essere neppure lontanamente assimilata ad un vero e proprio piano energetico, condiviso con i territori interessati e coerente con gli obiettivi energetici e di contrasto al cambiamento climatico perseguiti a livello europeo, impegna il Governo: 1) a promuovere, anche con misure di carattere normativo, gli investimenti in impianti e reti di distribuzione locali, al fine di garantire un approvvigionamento elettrico sicuro, rendendo così possibile, per le imprese e i cittadini, lo sviluppo di progetti per la produzione di elettricità e calore da fonti energetiche rinnovabili e la gestione al servizio di condomini, case, uffici, attività produttive; 2) a promuovere lo sviluppo di sistemi di accumulo dell'energia elettrica al fine di aumentare la flessibilità e l'efficienza delle reti elettriche e di contribuire anche alla fornitura dei servizi indispensabili alla sicurezza del sistema elettrico a seguito della crescente penetrazione di fonti rinnovabili, contribuendo così anche a ridurre la dipendenza dall'acquisto di carburanti fossili per la produzione di energia elettrica e termica; 3) ad adottare ogni opportuna iniziativa per favorire tutte le forme di autoproduzione di energia elettrica e termica, permettendo così a famiglie, condomini, aziende, distretti produttivi e utenze distribuite di diventare indipendenti o di ridurre gli approvvigionamenti dalla rete; 4) ad avviare una nuova politica energetica per la riduzione progressiva dell'uso del carbone per la produzione di energia elettrica fino al definitivo abbandono e la riconversione delle centrali termoelettriche che oggi utilizzano olio combustibile o carbone; 5) a sospendere tutti i procedimenti autorizzativi in corso per la realizzazione di nuove centrali a carbone e ad assumere iniziative per adottare una moratoria per tutte le nuove centrali termoelettriche, a biomassa, a rifiuti ed ibride attualmente in fase di valutazione, progettazione e attuazione. (1-00298)