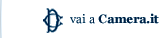Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00556 presentata da SEGONI SAMUELE (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 05/01/2015
Atto Camera Risoluzione in commissione 7-00556 presentato da SEGONI Samuele testo di Lunedì 5 gennaio 2015, seduta n. 357 L'VIII Commissione, premesso che: nel periodo compreso fra il 1979 ed il 2002, il catalogo del CNR IRPI ( http://sici.irpi.cnnit/dannipersone.htm ) riporta 4521 eventi calamitosi che hanno causato morti, dispersi, feriti, sfollati e senzatetto, di cui 2366 relativi a frane (52,33 per cento), 2070 ad inondazioni (45,79 per cento), e 85 a valanghe (1,88 per cento). I morti per frana sono stati almeno 10.032, i dispersi 85 ed i feriti 2265. I morti per inondazione sono stati oltre 20.754, i dispersi 121, e i feriti almeno 2366; secondo dati del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare elaborati sulla base dei piani di assetto idrogeologico (PAI) redatti dalle autorità di bacino, regioni e province autonome, i comuni interessati da aree ad alta criticità idrogeologica sono 6.633, pari all'81,9 per cento dei comuni italiani (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare). Il rischio idrogeologico in Italia, 2008); le aree a alta criticità idraulica sono pari a 12.263 chilometri quadrati, quelle soggette a criticità idraulica sono pari a 23.903 chilometri quadrati per una popolazione esposta di 6.154.011 abitanti (elaborazione ISPRA 2012); l'Italia inoltre è il paese europeo maggiormente interessato da fenomeni franosi. L'inventario dei fenomeni franosi in Italia (Progetto IFFI – realizzato da ISPRA in collaborazione con le regioni e province Autonome) ha censito 499.511 frane (pari a circa il 70 per cento delle frane mappate in Europa), che interessano un'area di 21.182 chilometri quadrati pari al 7 per cento del territorio nazionale. Questi numeri, di per sé impressionanti, devono tuttaviaessere considerati delle stime in difetto visto che la mappatura non è aggiornata su tutto il territorio nazionale e che ogni anno si verificano oltre un migliaio di frane, di cui circa un centinaio causano vittime, feriti, evacuati e danni a edifici e infrastrutture lineari di comunicazione primarie. Sempre secondo stime di ISPRA, la popolazione esposta a fenomeni franosi in Italia ammonta a 1.001.174 abitanti; le concause della peculiare situazione italiana possono essere ascritte sia ad elementi naturali che ad elementi antropici. Tra i primi sono sicuramente da annoverare la forzante meteorologica e la predisposizione geomorfologica del territorio: l'Italia infatti è una terra geologicamente molto giovane e deve ancora trovare un proprio equilibrio geomorfologico, soprattutto alla luce dei mutamenti climatici in atto. Questa considerazione non deve servire da alibi per coprire le evidenti responsabilità dell'uomo che possono essere riassunte in tre elementi principali: una gestione del territorio non sempre oculata e compatibile con le dinamiche naturali dei versanti e dei corsi d'acqua, una drammatica mancanza della cultura del rischio sia nella cittadinanza che negli amministratori, un'organizzazione della macchina amministrativa che non agevola risposte tempestive al problema del dissesto idrogeologico; in uno scenario nazionale così complesso e con un territorio geomorfologicamente in costante evoluzione, l'attività del servizio nazionale della protezione civile (nata con la legge la legge n.225 del 1992, con il compito di «tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e altri eventi calamitosi») assume un ruolo di rilevanza vitale in quanto si occupa, oltre che del soccorso e delle attività volte al superamento dell'emergenza, anche della previsione e della prevenzione, fondandosi sul principio di sussidiarietà (regolamentato dal decreto legislativo n.112 del 1998 e ulteriormente modificato dalla legge costituzionale n.3 del 2001); a vent'anni di distanza dalla sua fondazione, il Servizio nazionale della protezione civile è stato riformato recentemente con il decreto legge n.59 del 15 maggio 2012 (convertito dalla legge n.100 del 12 luglio 2012) in cui si sottolineano per la prima volta i concetti di «allertamento», «pianificazione d'emergenza», «formazione», «diffusione della conoscenza di protezione civile», «informazione alla popolazione», «applicazione della normativa tecnica» ed «esercitazioni» e in cui una novità importante è costituita dai piani comunali di emergenza (che devono essere redatti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, e periodicamente aggiornati); il piano d'emergenza (che recepisce il programma di previsione e prevenzione) è lo strumento che consente alle autorità di predisporre e coordinare gli interventi di soccorso a tutela della popolazione e dei beni in un'area a rischio, ha l'obiettivo di garantire con ogni mezzo il mantenimento del livello di «vita civile» che può essere messo in crisi da una situazione che comporta gravi disagi fisici e psicologici ed è soprattutto un documento in continuo aggiornamento, che deve tener conto dell'evoluzione dell'assetto territoriale e delle variazioni negli scenari attesi; l'attuale Governo, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014, ha istituito la «struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche», nota anche con il termine giornalistico italiasicura, con la principale finalità di imprimere un'accelerazione all'attuazione degli interventi strutturali in materia di dissesto idrogeologico; al dottor Erasmo D'Angelis è stato assegnato l'incarico di dirigenza della struttura in questione con il compito di curare l'impulso, il coordinamento, il monitoraggio e il controllo in ordine alle funzioni di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi strutturali in materia di dissesto idrogeologico, siano essi di prevenzione o di messa in sicurezza post-eventi, con particolare riferimento a quelli previsti negli accordi di programma Stato-regioni nonché in tutti gli altri accordi fra pubbliche amministrazioni in cui vi sia allocazione di risorse statali, facenti capo, nelle materie sopra indicate, agli enti ed organi preposti; tale dirigente della struttura in questione ha anticipato che per i prossimi sette anni l'obiettivo è aprire circa 7.000 cantieri, attraverso un piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, prevedendo una spesa di quasi 9 miliardi di euro (5 provenienti dai fondi di sviluppo e coesione; 2 dal cofinanziamento delle regioni o dai fondi europei a disposizione delle regioni stesse e altri 2 miliardi recuperati dai fondi destinati alle opere di messa in sicurezza e non spesi fino ad ora) e che, in particolare, verranno aperti 654 cantieri entro la fine del 2014, per un totale di 807 milioni, e altri 659 cantieri nei primi mesi del 2015, per un valore pari ad un miliardo e 96 milioni di euro con l'obiettivo di promuovere una coscienziosa cultura del rischio sismico e idrogeologico; parallelamente, la società civile ed il mondo politico hanno organizzato diversi momenti di confronto come convegni e tavole rotonde (tra cui si cita, a titolo d'esempio, «Fuori dal fango! Gli stati generali contro il dissesto idrogeologico – organizzato l'11 novembre 2014 e “Italia dissestata. Convegno su frane e alluvioni in Italia e in Parlamento” – organizzato il 7 ottobre 2014)»; i massimi esperti nazionali intervenuti da una parte hanno preso atto che la politica sta mettendo finalmente la prevenzione del dissesto idrogeologico tra i propri obiettivi, dall'altra hanno riscontrato come criticità il fatto che tale azione preventiva viene esercitata solo tramite cosiddetti interventi strutturali (opere di sistemazione attiva o passiva che mirano a ridurre la pericolosità dell'evento abbassando la probabilità di accadimento oppure attenuandone l'impatto), mentre gli interventi di tipo non strutturale (azioni finalizzate alla riduzione del danno attraverso l'introduzione di vincoli, la pianificazione dell'emergenza, la realizzazione di sistemi di previsione, allertamento e monitoraggio) risultano fortemente minoritari; la presente risoluzione raccoglie parte delle istanze emerse dai sopra citati momenti di confronto e interviene su aspetti (interventi non strutturali) che possono essere ritenuti complementari a quelli su cui attualmente si concentra prioritariamente l'azione dell'unità di missione (interventi strutturali); considerando l'impossibilità di azzerare il rischio idrogeologico in tutta Italia, è necessario sviluppare maggiormente la capacità di prevedere le emergenze e fare in modo che gli amministratori e la cittadinanza siano in grado di attivarsi prontamente per rispondere e mettere in atto tutte le contromisure necessarie. Appare particolarmente urgente disporre norme per contenere il consumo di suolo, per contrastare l'impermeabilizzazione dello stesso (che favorisce la formazione di alluvioni lampo e di ondate di piana concentrate) e per favorire lo sviluppo di un tessuto urbano e produttivo resiliente, ovvero capace di assorbire meno traumaticamente possibile gli eventi estremi e le dinamiche naturali dei versanti e del reticolo idrografico. Nell'ottica di sviluppare una società resiliente, è opportuno ricordare che quello del dissesto idrogeologico è un problema anche culturale, di percezione e conoscenza del rischio. Tra gli indirizzi proposti inoltre sono presenti anche impegni che mirano a superare alcune criticità che caratterizzano la pubblica amministrazione, tra cui la sovrapposizione di competenze tra enti, la mancanza di personale altamente specializzato in grado di riconoscere le dinamiche idro-geo-morfologiche e di prevedere l'evoluzione dei processi, l'assenza di strutture in grado di occuparsi di geologia di base e geologia applicata in maniera omogenea e continua su tutto il territorio nazionale, impegna il Governo: a promuovere l'aggiornamento regolare della mappatura delle aree esposte a rischio idrogeologico e delle fonti di pericolosità, integrando i vari quadri conoscitivi tra loro e con gli strumenti urbanistici, al fine di subordinare la pianificazione territoriale alle conoscenze tecnico-scientifiche sulla pericolosità idrogeologica; ad assumere iniziative dirette a riorganizzare le competenze in materia di dissesto idrogeologico degli organi territoriali, sia di primo che di secondo livello, al fine di evitare sovrapposizioni e conflitti nella progettazione ed assicurandosi che le decisioni politiche in materia di assetto e pianificazione del territorio siano prese in base ad adeguati presupposti tecnico-scientifici; ad assumere un'iniziativa normativaaffinché ogni variazione della strumentazione urbanistica generale e/o attuativa vigente che comporti aumenti delle previsioni edificatorie ovvero che renda, edificabili nuove aree (comprese quelle finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico) possa avvenire solo previo parere positivo espresso dall'autorità di bacino (o distretto idrografico); assumere un'iniziativa normativa affinché il rilascio del permesso a costruire sia subordinato alla presentazione di un «certificato di sicurezza», asseverato da un tecnico specialista, che quantifichi il rischio idrogeologico a cui è esposto l'immobile e che sia allegato agli atti di compravendita; a individuare un opportuno cofinanziamento per la manutenzione e il potenziamento delle reti strumentali, sia da terra che satellitari, utili alla previsione e al monitoraggio delle condizioni meteorologiche, idrauliche e idrogeologiche; ad assumere ogni iniziativa di competenzaper favorire l'omologazione e la standardizzazione, su base nazionale, dei criteri, della terminologia e dei codici colore adottati dai vari enti territoriali per classificare e gestire le situazioni di emergenza; a destinare una piccola parte dei fondi individuati per la prevenzione del dissesto idrogeologico anche al finanziamento di progetti di ricerca scientifica applicata inerenti alla mitigazione del rischio idrogeologico ai fini di protezione civile, con particolare riferimento a progetti per il potenziamento delle capacità previsionali degli effetti al suolo degli eventi estremi; ad assumere iniziative normative per l'istituzione di un servizio geologico nazionale in cui ISPRA coordini e metta in rete i servizi geologici regionali (in capo alle ARPA o alle regioni), al fine di fornire supporto alla pianificazione territoriale, monitorare e aggiornare costantemente gli interventi e le situazioni di rischio, aggiornare e omogeneizzare le mappature tematiche come la cartografia geologica di base alla scala 1:50.000 e l'inventario dei fenomeni franosi; a promuovere, con l'opportuno coinvolgimento dei volontari della protezione civile e degli ordini professionali, programmi per l'apprendimento dei comportamenti idonei da tenere in caso di allerta per fenomeni meteo, idrogeologici e sismici, con particolare riferimento a specifici programmi rivolti agli istituti scolastici pubblici e privati, dalla scuola dell'infanzia agli istituti superiori. (7-00556) « Segoni , Terzoni , Zolezzi , De Rosa , Daga , Busto , Mannino , Micillo , Artini , Tofalo ».