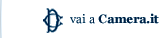Documenti ed Atti
XVIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00032 presentata da MURONI ROSSELLA (LIBERI E UGUALI) in data 30/07/2018
Atto Camera Risoluzione in commissione 7-00032 presentato da MURONI Rossella testo di Lunedì 30 luglio 2018, seduta n. 34 Le Commissioni VIII e IX, premesso che: a differenza di altri macro-settori, dal 1990 a oggi quello dei trasporti ha aumentato le proprie emissioni climalteranti (CO 2 ), del 23 per cento in Europa (EU28) e del 9 per cento in Italia. Il settore dei trasporti è divenuti la prima causa di emissioni di CO 2 equivalenti con il 27 per cento del totale (2016), superando le emissioni generate dalla produzione di elettricità e dall'industria. In Italia la quota di emissioni generate dai trasporti è in linea con la media europea; le ragioni della mancata diminuzione delle emissioni del sistema dei trasporti in Italia sono distribuite, secondo il parere tutti gli esperti, tra un incremento della mobilità di merci e passeggeri (+ 34 veicoli per chilometro delle percorrenze su strada delle merci e + 17 per cento dei passeggeri) e una troppo contenuta diminuzione delle emissioni specifiche (CO 2 a Km) a causa di un miglioramento delle tecnologie inferiore alle attese, soprattutto nell'uso reale; tra il 2000 e il 2015, a livello globale, il consumo di energia del settore trasporti è cresciuto del 35 per cento; oggi corrisponde a quasi un quarto dei consumi energetici del pianeta. Il livello di motorizzazione nell'Europa dell'Est, in Cina, Russia e America del Sud è in costante crescita; il fermento industriale attorno alla mobilità elettrica e alle batterie, il clima di crescente preoccupazione riguardo alla qualità dell'aria nei centri urbani, l'avvio di una discussione politica – in alcuni Paesi dell'Unione europea e in Cina e India – sulla messa al bando dei motori a combustione interna, segnalano che si potrebbe essere sul limitare di un profondo cambiamento; elettrificazione della mobilità privata, sistemi di sharing mobility sempre più articolati e semplici da usare, mobilità collettiva in sede protetta con tempi affidabili e aggiornamenti sugli smartphone , strade e piazze libere dalle auto e quindi sicure per gli spostamenti a piedi e in bicicletta ma anche per ripiantare alberi e creare spazi per una diversa vivibilità urbana: questi sono alcuni dei punti fondamentali per cambiare la città e la vita dei cittadini; gli italiani sono divisi sui provvedimenti da attuare per limitare il problema dell'inquinamento: il 46 per cento è preoccupato al punto di chiedere maggiori limitazioni alla vendita e alla circolazione di mezzi inquinanti, il 48 per cento considera invece inutili ulteriori limitazioni. Il 17 per cento degli italiani dichiara agli intervistatori di conoscere e di aver tenuto in considerazione anche le posizioni in tema ambientale espresse dal proprio partito per scelta di voto; si stanno introducendo divieti di circolazione sempre più severi per i veicoli a combustione nei centri città (Firenze da 2020, Roma dal 2024) e poi in tutte le aree urbane inquinate (Milano dal 2025 tutta gasolio free e dal 2030 tutto il trasporto pubblico sarà elettrico). A tal proposito è interessante notare che il 2030 è la data dichiarata anche in alcuni programmi elettorali dei partiti; le politiche per la realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile rappresentano, a livello mondiale, una leva strategica utile per perseguire la riduzione delle emissioni climalteranti finalizzate al contenimento del surriscaldamento globale, in linea con gli obiettivi stabiliti con l'accordo di Parigi - COP 21; il Ministero allo sviluppo economico dovrebbe predisporre entro dicembre 2018 il Piano energia e clima, che ridefinirà, anche per il settore mobilità e trasporti, le fonti energetiche e le emissioni climalteranti attribuibili all'Italia al 2030, in relazione agli impegni internazionali, in parte vincolanti; la III Conferenza mondiale Habitat sullo sviluppo urbano sostenibile che si è tenuta dal 17 al 20 ottobre 2016 a Quito (Ecuador) ha elaborato la nuova Agenda urbana delle Nazioni Unite per i prossimi venti anni; nel 2017 i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico hanno reso pubblico il documento «Elementi per una Roadmap della mobilità sostenibile», frutto dell'incontro di un gruppo di lavoro partecipato (e in parte firmato) da oltre 130 istituzioni e stakeholder che si sono ritrovati a Palazzo Chigi tra la primavera del 2017 e i primi mesi 2017, ma tale documento non è mai stato recepito dal Governo; come rilevato dal documento «Elementi per una roadmap della mobilità sostenibile», redatto con il supporto scientifico di Rse, solo veicoli elettrici alimentati da fonti rinnovabili, e biocarburanti in sostituzione integrale a quelli fossili costituiscono un rilevante contributo alla riduzione delle emissioni; nel maggio 2017 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte legislative volte a realizzare, entro il 2025, un sistema di trasporti pulito, competitivo e interconnesso; tra gli obiettivi delle proposte presentate dalla Commissione europea ci sono tra gli altri: promuovere la sostenibilità; modificare il comportamento dei consumatori e i modelli di domanda; garantire la sicurezza stradale; migliorare il quadro sociale e le condizioni di lavoro nel settore dei trasporti su strada; ridurre le emissioni di CO 2 l'inquinamento atmosferico e la congestione del traffico; incoraggiare l'adozione di sistemi di pedaggio più equi; ridurre gli oneri burocratici per le imprese; le stime reali delle emissioni dei veicoli Euro 6 prese in considerazione dal sistema delle Agenzie per l'ambiente per il catasto delle emissioni attribuiscono ai veicoli a combustione interna moderni circolanti in Italia valori variabili tra 168 grammi a chilometro per i veicoli a gas e 192 grammi per i diesel, ben lungi dai valori previsti dai valori di riferimento previsti dall'Europa (130 grammi oggi e 95 grammi dal 2021); secondo le stime più accreditate, anche con l'entrata in vigore delle nuove procedure di prova (più realistiche) e dei nuovi limiti alle emissioni in sede di omologazione dei nuovi veicoli immessi sul mercato, la stima delle emissioni reali di CO 2 dei veicoli a combustione, non scenderanno, neanche nel 2025, al di sotto dei 100-130 grammi di CO 2 a chilometro e, per questa ragione, sarà necessario introdurre obblighi vincolanti e crescenti di Zev ( zero emission vehicle ) come in California (e in altri 10 stati USA) e in Cina; ai costi ambientali e sanitari dell'inquinamento da traffico, si devono aggiungere l'incidentalità e la mancata riduzione della mortalità sulla strada: l'Italia si era impegnata di fronte all'Europa a scendere al di sotto 2.700 morti per incidenti nel 2017 e 2.500 nel 2020 e invece si è chiuso il 2016 a 3.283 e il 2017 sopra i 3.300; l'Istat, così come l'Osservatorio Audimob, a cura di Isfort, che monitora semestralmente la mobilità degli italiani, ha appurato come la crisi, come i costi crescenti nell'uso dell'automobile, sta ampliando la popolazione «non mobile», sino al 25 per cento (2012-2013) e come la lenta uscita dalla crisi ancora non abbia restituito mobilità ad una parte della popolazione, soprattutto la mobilità «non obbligata» da ragioni di lavoro, di studio, di necessità; nuove differenze sociali, legate all'accesso a servizi di mobilità socialmente sostenibili per le fasce deboli della popolazione, non sono legate alla disponibilità di un'ampia flotta di autoveicoli, con costi di gestione relativamente contenuti (38 milioni di veicoli, che pagano pochissimo di bollo, manutenzione), ma piuttosto ad un elevato costo di uso (carburante, consumi, assicurazione) e alla mancanze di alternative poco costose (linee comode di trasporto pubblico, percorsi sicuri in bicicletta o e-bike o veicoli leggeri, servizi di car sharing ): differenze quindi decisamente più accentuate fuori dalle aree urbane del centro nord; come ben illustrato dal dossier di Legambiente «Vie libere alla micromobilità elettrica», la diffusione di mezzi che permettono spostamenti leggeri di prossimità oppure l'intermodalità (con treno, trasporto pubblico locale o auto) in ambito urbano o interurbano, anche con motori elettrici, possono rappresentare una soluzione nuova, economicamente ed ambientalmente sostenibile, ma richiedono di essere normati e controllati sotto il profilo della sicurezza da un aggiornamento del Codice della strada; sempre nella chiave della sicurezza e della crescita della sostenibilità sono le richieste di associazioni come Fiab (Federazione italiana associazioni amici della bicicletta) di revisione del codice della strada: tanto più che la mobilità leggera sembra, allo stato del mercato internazionale, dalla Cina all'Europa, la grande favorita dall'elettrificazione (in Cina nel 2016 sono state vendute 300 mila auto elettriche e 30 milioni di ebike e scooter elettrici, in Europa a fronte di 200 mila ecar , 3 milioni di 2 ruote elettriche); gli scenari possibili di mobilità futura, elettrica, connessa, condivisa e sempre più intermodale (si useranno più mezzi per compiere lo stesso viaggio) fanno pensare ad un riequilibrio del parco nazionale disponibile: Legambiente (in « Green Mobility ». Edizioni ambiente, 2018) ipotizza 18 milioni di mezzi di mobilità elettrica leggera, 18 milioni di quadricicli e automobili, contro un parco attuale di 38 milioni di automobili endotermiche, scarsamente utilizzate e altamente inquinanti; la leva fiscale è stata determinante in questi anni nel determinare le scelte di mobilità dei cittadini: il gettito fiscale complessivo generato dal settore dei trasporti e dell’ automotive in particolare, così come i costi e gli investimenti nel bilancio dello Stato attribuibili allo stesso settore sono rilevanti: 73 miliardi di euro all'anno, il 15 per cento circa del gettito fiscale complessivo; le stime di Legambiente (« Green Mobility ». Edizioni ambiente, 2018) sul gettito fiscale di un sistema di trasporti completamente elettrico, con la fine delle accise sui carburanti fossili, anche prevedendo un raddoppio del bollo (tasse di proprietà) e dei pedaggi (parcheggi, pedaggi urbani e stradali), prevedono un dimezzamento del gettito fiscale complessivo del settore e una riduzione della spesa pubblica necessaria per mitigare gli effetti sanitari, ambientali, di incidentalità e in infrastrutture; le tasse di proprietà (di possesso) di veicoli a motore sono diventate irrisorie, soprattutto per i mezzi di lavoro, sino all'assurdo che 1 metro quadro di occupazione di suolo pubblico per tavolini di un bar in periferia a Milano o Roma, costa quanto il bollo di un camion da 3,5 tonnellate che occupa in sosta almeno 15 volte più spazio; le stime di Legambiente (sul 2016) su una possibile correzione delle accise che rendessero i costi del carburante proporzionali alle emissioni di CO 2 , a parità di gettito fiscale complessivo, attribuiscono alla benzina un costo di 1,33 euro al litro (contro ad una media nell'anno di 1,53), per il gasolio di 1,47 euro al chilogrammo (a fronte di 1,38), per il gpl di 0,89 euro al litro (invece di 0,63), per il metano di 1,52 euro al chilogrammo (0,96): la distorsione di consumi a vantaggio del gasolio è quindi stata indotta più da vantaggi fiscali che dall'effettiva efficienza dei motori a gasolio; i Pums, i piani urbani mobilità sostenibile, sono ormai riconosciuti dall'Unione europea e dallo Stato italiano (decreto ministeriale 4 agosto 2017) come lo strumento principale di governo locale della mobilità: sono l'unico strumento politico in mano ai comuni e alle città metropolitane per ridisegnare la mobilità (piano dotato di finanziamento, contrariamente ai Piani urbani del traffico) e lo spazio urbano (la previsione Pums fa variante urbanistica); nella Terza conferenza internazionale delle città dotate di Pums, i sindaci presenti hanno lanciato la «Carta di Brema» il 13 aprile 2016, in cui si afferma, al punto 1, che «Parlare di efficienza dei trasporti significa innanzitutto pensare a un uso efficiente dello spazio stradale. Lo spazio stradale è una risorsa preziosa e limitata», mentre il Pums del comune di Milano afferma nelle sue linee guida che «lo spazio pubblico è bene comune»; al tempo stesso bisogna ridisegnare lo spazio pubblico delle città. Le politiche della mobilità hanno guardato in questi soprattutto alle infrastrutture e ai veicoli in circolazione. Come invece dimostra l'esperienza di successo di tante città europee occorre mettere al centro dell'attenzione il ridisegno dello spazio urbano per restituire spazi alla mobilità pedonale, ciclabile, ai mezzi pubblici in sede protetta, con risultati positivi in termini di accessibilità e di qualità e vivibilità delle città; i percorsi ciclabili non devono limitarsi a offrire servizi di mobilità, ma devono cambiare radicalmente lo shift modale e diventare occasioni per il miglioramento qualitativo, funzionale ed estetico del tessuto urbano e per diffusi interventi di redistribuzione dello spazio pubblico, sottraendolo alle auto e restituendolo alle persone e alla vita comunitaria. Esempio di un nuovo modo di inserire un'opera pubblica in un contesto metropolitano è il Grab, il Grande raccordo anulare delle bici capitolino. Il progetto della ciclovia realizzato dai cittadini e dalle associazioni (tra cui Legambiente) e finanziato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è un'infrastruttura leggera e ad alta redditività ambientale, sociale, economica e culturale che punta non solo a far crescere gli spostamenti in bici ma a migliorare i luoghi che attraversa senza aggiungere volumetrie e cemento in un territorio massivamente edificato; il deferimento dell'Italia alla Corte di giustizia europea per aver violato ripetutamente i limiti di polveri sottili (Pm10) nei propri centri urbani e l'avvio della procedura anche per il superamento dei limiti di NO 2 , impongono (anche) all'Italia una revisione della pianificazione nazionale e regionale atta ad arginare l'inquinamento sia con misure d'emergenza immediatamente efficaci (blocchi stagionali della circolazione o abbassamento del riscaldamento) che con politiche strutturali di medio lungo termine (veicoli ed abitazioni a quasi o zero emissioni); la decisione del deferimento purtroppo non è una sorpresa. Legambiente, insieme a Cittadini per l'aria e all’ European Environmental Bureau (EEB), aveva già denunciato nei mesi scorsi come le misure antismog sottoposte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al giudizio dell'Unione europea non coprivano tutti i settori in cui bisognerebbe intervenire in maniera drastica, con un'applicazione stringente per essere efficaci e risolutive; occorrerebbe: a) estendere il protocollo antinquinamento Governo-regioni per la lotta all'inquinamento, oggi attivo solo per la pianura Padana, a tutta Italia e introdurre misure più severe per la circolazione dei veicoli più inquinanti (blocco stagionale Euro3 diesel ed Euro2 benzina). Così come è indispensabile introdurre misure di limitazione della velocità nelle strade e, soprattutto nelle autostrade, in funzione dei livelli di inquinamento sia invernali che estivi (ozono e smog fotochimico) come già fanno tutte le nazioni confinanti, con l'Italia (Francia, Svizzera, Austria e Slovenia); b) incentivare e diffondere la mobilità ciclistica, creando un contesto generale amico della bicicletta, nel quale sia possibile per un ciclista muoversi ovunque in modo confortevole e sicuro; si produrrebbero in tal modo dei benefici di cui gioverebbero anche tutti gli altri utenti della città; c) sviluppare gli interventi di moderazione del traffico e le zone 30, quali strumenti in assoluto più importanti su cui deve potersi basare qualunque politica per la ciclabilità; d) applicare gli strumenti di pianificazione forniti dal piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) dotandosi di strumenti specifici quale il piano della ciclabilità, affinché le politiche amministrative per la mobilità vengano attuate il più possibile in un'ottica metropolitana, e di continuità di rete, attraverso processi noti in anticipo e condivisi con i cittadini; e) potenziare e ripensare il servizio di trasporto pubblico in genere, come risorsa, per soddisfare anche le esigenze degli utenti con bici al seguito, favorendo l'intermodalità, la realizzazione di bicistazioni, servizi di bike sharing , parcheggi per bici diffusi, adeguati e sicuri, impegnano il Governo: a predisporre, parallelamente al piano energia e clima, entro il 2018, una « road map mobilità e trasporti 2030» governativa, con obiettivi coerenti e proporzionati agli impegni internazionali di riduzione delle emissioni climalteranti e sanitariamente ed ambientalmente rilevanti; a predisporre, entro il 2019, il nuovo piano generale dei trasporti e della logistica, introducendo dei target di mobilità sostenibile per le merci e per i passeggeri su gomma, ferro e via mare; ad assumere le iniziative di competenza per elaborare, in coerenza con quanto definito nei piani strategici, l'insieme delle misure riformatrici necessarie modificando il codice della strada; a predispone uno studio, da portare all'attenzione delle parti sociali, di riforma dell'apparato fiscale che grava sul sistema dei trasporti di lungo periodo, che accompagni coerentemente la pianificazione strategica di trasformazione della mobilità e dei trasporti in Italia e la possibile riorganizzazione della spesa pubblica relativa al settore; a inserire nel disegno di legge di bilancio per il 2019 le prime misure di incentivo e disincentivo ( bonus-malus ) della mobilità sostenibile, andando oltre la logica della rottamazione (sostituzione di un veicolo più inquinante con uno un po’ meno inquinante), ad esempio: a) spostando il carico fiscale soprattutto sui carburanti che generano maggior inquinamento (ad esempio costo finale proporzionale alle emissioni di CO 2 ); b) riequilibrando il carico fiscale dall'uso alla proprietà dei mezzi di trasporto e favorendo piuttosto la condivisione ( sharing ), l'uso pubblico l'acquisto e l'uso di Zev ( zero emission vehicle ) e tassando proporzionalmente i veicoli a combustione interna nuovi in base alla massa e alla potenza; c) accompagnando queste misure con la previsione in ambito nazionale dell'obbligo assegnato ai costruttori e agli importatori di quote di mercato di veicoli elettrici (ZEN): 1 per cento nel 2019 e crescente negli anni successivi (sino al 100 per cento nel 2030); a ridefinire e dare maggiore coerenza al piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, all'Osservatorio Pums (Piani urbani di mobilità sostenibile) e agli strumenti finanziari (piano annuale di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) a sostegno di quei comuni che si sono dotati di Pums con obiettivi sfidanti e coerenti, oppure di quei territori, anche turistici, che si sono dotati di piani di accoglienza e mobilità sostenibili; a predisporre una revisione della pianificazione e degli strumenti di intervento per ottemperare agli obblighi di risanamento della qualità dell'aria, sia per rientrare rapidamente negli obblighi europei per superare la procedura di infrazione in corso, sia per rispettare i valori guida di esposizione sanitariamente rilevanti, a tal fine assumendo le iniziative di competenza per assegnare obblighi coerenti agli enti gestori e alle autorità che sfuggono ai poteri regionali (autostrade, porti, aeroporti) e attribuire, nelle procedure di infrazione, responsabilità e oneri a carico delle regioni inadempienti; a predisporre un piano nazionale della ciclabilità con concrete azioni finalizzate ad incentivare e favorire l'uso della bicicletta, con particolare attenzione al piano della rete degli itinerari ciclabili, nel quale siano previsti gli interventi da realizzare, comprensivo dei dati sui flussi ciclistici, delle lunghezze dei tracciati, della stima economica di spesa e di una motivata scala di priorità e di tempi di realizzazione; ad adottare iniziative per prevedere una norma che stabilisca la destinazione di una quota delle contravvenzioni alla ciclabilità, con particolare attenzione agli interventi sulla sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili), prevedendo annualmente le quote da destinarsi alle suindicate finalità; ad adottare iniziative per prevedere, oltre alle infrastrutture riservate alla bicicletta (piste ciclabili, passerelle, sottopassi), utili per sviluppare la mobilità ciclistica, anche tutti gli interventi che costituiscono l'applicazione dei princìpi e dei criteri di moderazione del traffico, facendo sì che queste misure siano finalizzate ad intervenire sul traffico automobilistico privato, creando le condizioni fisiche per renderlo compatibile con le altre forme di mobilità (mezzi pubblici, ciclisti e pedoni) e con le diverse funzioni urbane, riducendo le possibilità di conflitto e dunque realizzando concretamente la coesistenza in sicurezza tra la mobilità motorizzata e le altre. (7-00032) « Muroni , Stumpo , Fornaro , Rostan , Del Barba , Gribaudo ».