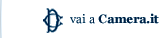Documenti ed Atti
XVIII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00061 presentata da LOREFICE PIETRO (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 19/01/2021
Atto Senato Risoluzione in Commissione 7-00061 presentata da PIETRO LOREFICE martedì 19 gennaio 2021, seduta n.213 La 14ª Commissione permanente, esaminate le proposte di regolamento COM(2020) 610, 611, 612, 613 e 614, di riforma del sistema europeo comune d'asilo e di implementazione del nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo (COM(2020) 609), concernenti, rispettivamente, il regolamento Dublino, la procedura di asilo alla frontiera, gli accertamenti pre-ingresso, le situazioni di crisi e il sistema Eurodac; considerate le relazioni del Governo trasmesse ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, sulle proposte COM(2020) 610 (sistema Dublino), 611 (protezione internazionale), 612 (accertamenti pre-ingresso), 613 (situazioni di crisi) e 614 (Eurodac), e l'audizione del Ministro dell'interno, svolta il 12 gennaio 2021; ritiene non rispettati i principi di sussidiarietà e proporzionalità, per i motivi illustrati di seguito. Il fenomeno dei flussi migratori è strutturalmente transfrontaliero e di difficile gestione da parte dei singoli Stati membri; è necessaria una totale e più compiuta competenza a livello unionale nella loro gestione in cui l'azione dei singoli Stati membri sia improntata secondo i principi di cui all'articolo 80 del TFUE per cui "le politiche dell'Unione [...] sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri [...]", dove la solidarietà trovi il giusto equilibrio con una responsabilità condivisa attraverso strumenti e procedure obbligatorie nella loro applicazione. La 14ª Commissione ritiene anzitutto necessario mantenere ferma la "logica di pacchetto" per le proposte in esame, al fine di permettere una visione unitaria dei suoi diversi aspetti e di valutarne l'effettiva portata complessiva, soprattutto in relazione al necessario equilibrio tra gli obblighi di responsabilità previsti in capo agli Stati di primo approdo e il sistema di solidarietà da parte degli altri Stati membri dell'UE. Le proposte, infatti, presentano una manifesta asimmetria tra l'obbligatorietà delle procedure alle frontiere esterne, incluse quelle di pre-ingresso, con finalità di prevenzione dei movimenti secondari, in capo agli Stati di primo approdo, e le formule di solidarietà flessibile la cui obbligatorietà per gli altri Stati membri è del tutto aleatoria. Da questo punto di vista, le proposte di riforma del sistema europeo vigente non modificano le problematiche attuali derivanti dall'applicazione del principio della responsabilità del Paese di primo ingresso che viene quindi mantenuto fermo, e non rappresentano pertanto alcun "valore aggiunto" dell'azione a livello di Unione, che è elemento necessario ai fini del rispetto del principio di sussidiarietà e che sarebbe presente solo qualora fossero previsti meccanismi in grado di bilanciare in modo efficace gli oneri che gravano sullo Stato di primo ingresso, tra cui l'effettiva obbligatorietà dei ricollocamenti negli altri Stati membri. In particolare, la proposta COM(2020) 610, pur abrogando e sostituendo il regolamento Dublino, mantiene il criterio del primo ingresso per la determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, a differenza della risoluzione del Parlamento europeo del 16 novembre 2017, in cui l'ingresso in qualsiasi Stato membro è considerato come ingresso nell'Unione e in cui sono previsti criteri innovativi, che prescindono da quello dello Stato di primo ingresso, per l'individuazione dello Stato competente. Nella Risoluzione del 17 dicembre 2020 sull'attuazione del regolamento Dublino III, sempre il Parlamento europeo ritiene che lo stesso attualmente in vigore "[...] faccia gravare una responsabilità sproporzionata su una minoranza di Stati, soprattutto nei periodi di grande afflusso di migranti; ritiene che il criterio del primo ingresso stabilito dal regolamento Dublino III abbia gravato, in ragione della loro posizione geografica, in maniera sproporzionata e come mai in precedenza sui paesi in prima linea in termini di registrazione e accoglienza dei richiedenti asilo; sottolinea che il regolamento Dublino III, così come concepito e attuato, non è riuscito a garantire il suo obiettivo principale, vale a dire la rapida determinazione dello Stato membro competente per una domanda di asilo, né ad assicurare quindi un'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri e un accesso efficace e rapido alle procedure di asilo" e ancora evidenzia che "[...] l'inadeguata applicazione della gerarchia dei criteri, segnatamente l'uso eccessivo del criterio del paese di primo ingresso e l'esecuzione inefficace dei trasferimenti, ha accresciuto in maniera sproporzionata le responsabilità incombenti ad alcuni Stati membri, in particolare quelli in prima linea; ritiene pertanto che l'UE necessiti di un meccanismo di solidarietà sostenibile che stabilisca norme eque per la ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, conformemente all'articolo 80 TFUE e nel pieno rispetto del diritto fondamentale alla sicurezza e alla protezione dei richiedenti asilo". D'altra parte, il nuovo meccanismo di solidarietà, previsto dalle proposte, risulta del tutto inidoneo a bilanciare gli oneri di responsabilità degli Stati di primo ingresso, potendo assumere le seguenti forme alternative: a) ricollocazione di richiedenti che non sono sottoposti alla procedura di frontiera per l'esame di una domanda di protezione internazionale; b) rimpatri sponsorizzati di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; c) ricollocazione di beneficiari di protezione internazionale cui è stata concessa protezione internazionale da meno di tre anni; d) misure di rafforzamento delle capacità in materia di asilo, accoglienza e rimpatrio, sostegno operativo e cooperazione con i Paesi terzi. Inoltre, si prevede che i ricollocamenti siano disposti con strumenti giuridici temporanei (atti di esecuzione) della durata di un anno e non è previsto né un sistema incentivante, né tantomeno un sistema sanzionatorio per quegli Stati membri inadempienti, a parte le tradizionali procedure di contenzioso, scarsamente persuasive in ambito di politiche migratorie. Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, non appare adeguato il sistema del "pre-ingresso" che, nella sua concreta attuazione, rischia di incidere eccessivamente sull'ordinamento giuridico nazionale e sulle tutele giurisdizionali che devono essere assicurate in base ai principi costituzionali, del diritto internazionale e del diritto europeo. Il "pre-ingresso" previsto nelle proposte COM(2020) 611 e 612, infatti, si sostanzia in una sorta di finzione giuridica - peraltro incompatibile con la realtà della gestione delle frontiere marittime - di un "non ingresso" nel territorio europeo di migranti irregolari, che rende poi necessari una serie di accorgimenti in termini di procedure obbligatorie alle frontiere esterne, incluse procedure di pre-ingresso, e apre la strada alla necessità di centri chiusi nei Paesi di primo ingresso, che rischiano quindi di essere trasformati negli hotspot per il resto d'Europa, in un momento in cui le conseguenze socio-economiche della pandemia rappresentano un preoccupante fattore di spinta alla migrazione. Tali procedure, che potrebbero presentare potenziali profili di incompatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, rimarrebbero, poi, del tutto a carico degli Stati di primo approdo, senza alcun meccanismo obbligatorio di condivisione degli oneri, abbandonando del tutto lo spirito de La Valletta del settembre 2019, in cui si delineava un sistema di solidarietà e di quote di ricollocamento dei migranti che giungono in territorio europeo attraverso operazioni di soccorso in mare, indipendentemente dal loro status di richiedente asilo. Dal punto di vista giuridico, l'articolo 4, paragrafo 1, della proposta COM(2020) 612, secondo cui, durante gli accertamenti previsti per lo screening le persone controllate non sono autorizzate a entrare nel territorio di uno Stato membro, realizza, come già accennato, una sorta di fictio juris, in base alla quale si presume che lo straniero, pur fisicamente presente nel territorio nazionale, non sarebbe considerato tale sino al completamento degli accertamenti. In tal senso, si pone il problema della qualifica giuridica del trattenimento nei centri deputati allo screening per la durata dello stesso come detenzione o meno. Più in generale, con tale sistema, l'accesso al territorio di uno Stato verrebbe svuotato del suo significato più tipico, ovvero di accesso ad un ordinamento e a un sistema di diritti, e di conseguenza a un sistema giurisdizionale per il rispetto di quei diritti. Va peraltro chiarita la definizione di "luoghi ubicati presso le frontiere esterne o nelle loro vicinanze", che sono deputati all'espletamento delle attività di screening, nonché le modalità di trattenimento in essi per cinque giorni, anche con riferimento agli stranieri richiedenti asilo. Ancora, l'obbligo di effettuare tale screening pre-ingresso e la previsione di un tempo massimo di 10 giorni, possono comportare problemi di capienza delle strutture attuali, con ripercussioni organizzative e finanziarie che gravano sugli Stati membri interessati. Inoltre, l'articolo 6, paragrafo 7, ultimo capoverso, della proposta COM(2020) 612, prevede solo la mera facoltà, per esperti o funzionari di collegamento o per il personale dell'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea e dell'Agenzia dell'UE per l'asilo, di prestare assistenza e sostegno alle attività di verifica svolte dalle Autorità competenti nazionali. Tale sistema, non è quindi idoneo a bilanciare il maggior onere derivante dalle norme proposte, gravando in maniera sproporzionata sui singoli Stati membri con frontiere esterne. Altro elemento che non rispetta il principio di proporzionalità è la previsione del requisito della soglia del 20 per cento di riconoscimento della protezione internazionale, al di sotto della quale deve essere attivata la procedura di frontiera e quindi non può essere dato corso alle procedure di ricollocamento, soprattutto in caso di approdo alle frontiere marittime. Infatti, la quasi totalità dei migranti marittimi rientra nei criteri di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettere c), f) o i), della proposta COM(2020) 611, e sarebbe quindi sottoposta alla procedura di frontiera, con conseguente esclusione dalle procedure di ricollocamento. Non appare in linea con il principio di proporzionalità, inoltre, la disciplina del meccanismo della sponsorizzazione dei rimpatri, che presenta un aggravio di costi e di adempimenti burocratici per lo Stato membro di primo approdo, beneficiario della sponsorizzazione, oltre a essere difficilmente realizzabile nel previsto periodo di otto mesi e in assenza di accordi di riammissione con i principali Paesi africani. Peraltro, si prevede che, nei primi otto mesi dall'ingresso, lo Stato membro sponsor svolga tutte le attività relative alla procedura di rimpatrio direttamente nel territorio dello Stato membro di primo ingresso, con conseguente scarso effetto benefico per lo Stato sotto pressione migratoria. A tale riguardo, la dimensione esterna è un elemento chiave del nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo ai fini dell'intensificazione e l'efficacia delle attività di rimpatrio e, come tale, dovrebbe andare di pari passo con tutte le altre proposte del pacchetto asilo e migrazione. L'approccio alle relazioni con i Paesi terzi, incentrato sulla stipula di accordi di riammissione e sulla migrazione legale, dovrebbe essere affrontato in modo energico e senza ulteriori ritardi a livello dell'Unione, prevedendo anche i necessari strumenti finanziari e politici, con particolare riguardo ai nostri Paesi vicini meridionali. (7-00061) LOREFICE, GINETTI